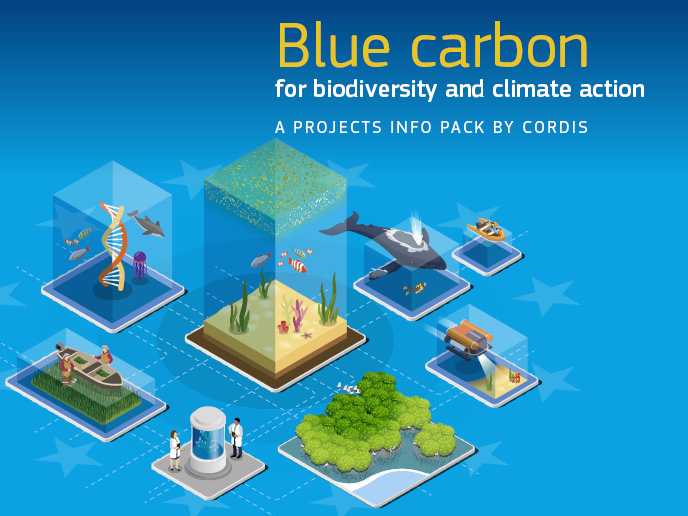Trovare le emissioni di gas a effetto serra nelle regioni ad alta latitudine
Le esatte modalità con cui la massa terrestre risponderà ai cambiamenti climatici sono ancora pervase da molte lacune, il che rende difficile verificare l’accuratezza delle attuali previsioni climatiche. Tra di esse, quelle relative alle regioni ad alta latitudine come l’Artico e gli ecosistemi boreali, che contengono notevoli riserve di carbonio nel loro suolo e potrebbero diventare enormi fonti nette di gas a effetto serra (GES): si tratta di aree che emettono anche metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), sebbene le stime di tali emissioni varino in maniera considerevole. La maggior parte degli studi si è incentrata sugli impatti climatici durante le stagioni di crescita delle piante, poiché le condizioni per effettuare le misurazioni in inverno sono piuttosto sfavorevoli e molte emissioni sono legate all’attività vegetale, caratterizzata da un picco in estate. «Le mutazioni del clima stanno facendo riscaldare questi periodi, da cui ne deriva che i processi del suolo continueranno probabilmente più a lungo in autunno e potenzialmente a un ritmo più elevato rispetto al passato», spiega Claire Treat(si apre in una nuova finestra), docente presso il dipartimento di Agroecologia dell’Università di Aarhus. «L’effetto netto esercitato da questi elementi sulle emissioni annuali è sconosciuto, ma la sua potenziale entità è elevata.» Per questo motivo, nell’ambito del progetto FluxWIN(si apre in una nuova finestra), finanziato dal Consiglio europeo della ricerca(si apre in una nuova finestra) (CER), Treat e i suoi colleghi si sono recati in aree situate ad alta latitudine per misurare direttamente i flussi di CH4 e N2O nel corso della stagione non vegetativa, così da ottenere un quadro più preciso degli impatti generati dai cambiamenti climatici.
Analizzare il flusso dei GES nella stagione non vegetativa in laboratorio e sul campo
«Il CER ci ha permesso di dare vita a un impianto sul campo davvero ben funzionante, dotato di camere automatizzate per misurare le emissioni di gas serra che sono in grado di operare anche in inverno», spiega Treat, che ha rivestito il ruolo di coordinatrice del progetto FluxWIN. I ricercatori hanno misurato le modalità attraverso cui le emissioni di CH4 variano all’interno di una zona umida, nonché nella vicina zona montana, e nel corso dell’anno per avvalersi successivamente di esperimenti sul campo e misure isotopiche di 13C-CH4 al fine di osservare come le componenti dei flussi di CH4 cambiassero su base annua. In laboratorio, quindi, l’équipe ha esplorato il modo in cui la produzione di CH4 e i tassi di decomposizione cambiano a seconda della temperatura.
Mettere in mostra la variabilità stagionale delle emissioni di CH4
I risultati che più entusiasmano Treat sono quelli della tesi della sua studentessa di dottorato Katharina Jentzsch, che presentano le differenze di variabilità stagionale delle emissioni di CH4 tra le diverse comunità vegetali. Mentre in alcune comunità le emissioni di CH4 si sono comportate esattamente come previsto seguendo l’attività delle piante, registrando un picco durante l’estate, in autunno, invece, i ricercatori hanno riscontrato pochi cambiamenti nelle emissioni delle comunità vegetali più secche, che sono diventate i componenti chiave delle emissioni su scala ecosistemica più ampia. «Se consideriamo la torbiera nel suo complesso, le emissioni autunnali di metano sono risultate più elevate di quanto ci saremmo aspettati a causa del contributo apportato da queste comunità vegetali secche», osserva Treat. Ciò indica che, per prevedere con precisione le emissioni annuali di CH4, la variabilità spaziale dovrebbe essere considerata all’interno delle zone umide, che attualmente non vengono integrate nei modelli.
Ispirare la ricerca sulle emissioni nella stagione fredda
Secondo Treat, il progetto ha stimolato altre ricerche, tra cui quella sul modo in cui le emissioni della stagione fredda sono rappresentate nei modelli del bilancio globale del carbonio sviluppati dal progetto CH4. «Nel complesso, mi auguro che ciò renda possibile che queste importanti emissioni vengano ora incluse nei bilanci globali del metano.» Il team intende ora lavorare con collaboratori dell’Università di Helsinki allo scopo di esaminare come i processi alla base dei flussi di CH4 differiscano tra due diversi tipi di zone umide comuni, ovvero le torbiere e gli acquitrini. «Ritengo che questo progetto abbia davvero contribuito a modificare il paradigma stimolando altri gruppi di ricerca che lavorano ad alte latitudini a continuare le misurazioni durante tutto l’anno, in modo da proseguire anche su scala maggiore!», conclude Treat.