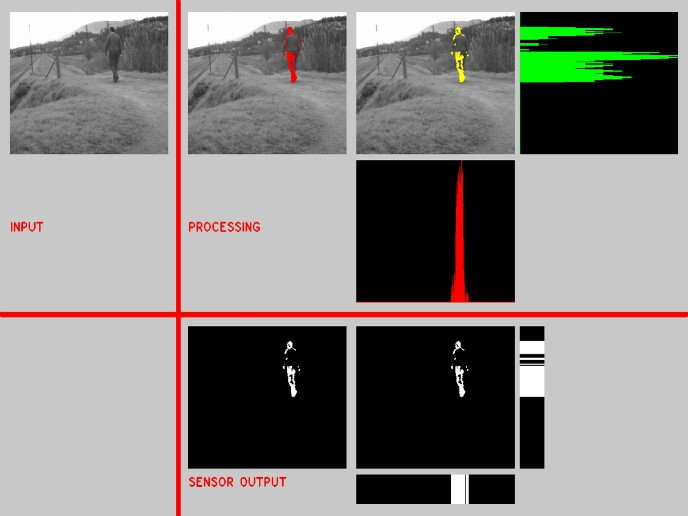Svelare i misteri della mummificazione
Sebbene le mummie rappresentino un caposaldo dell’archeologia, è sorprendente che gli archeologi abbiano una conoscenza limitata dei processi di mummificazione che precedono la sepoltura. «È difficile individuare il modo in cui vengono trattati i resti umani prima della loro deposizione finale», afferma Eline Schotsmans(si apre in una nuova finestra), borsista Marie Skłodowska-Curie(si apre in una nuova finestra) presso l’Università di Bordeaux(si apre in una nuova finestra) in Francia. Come spiega Schotsmans, ciò dipende dal fatto che, dopo migliaia di anni, la maggior parte dei tessuti molli preservati scompaiono. «Dato che la documentazione archeologica mostra solamente la deposizione finale dei resti umani, le pratiche mortuarie spesso non vengono considerate come un processo dinamico comprendente diverse fasi che si susseguono nell’arco di un determinato periodo di tempo», aggiunge. Sebbene siano diversi i metodi attualmente utilizzati allo scopo di individuare i processi di mummificazione che precedono la sepoltura, nessuno di essi è stato convalidato in modo adeguato. Ma con il sostegno del progetto ArchFarm, finanziato dall’UE, Schotsmans si è prefissa di cambiare questa situazione, un obiettivo che ha deciso di perseguire recandosi presso una fattoria dei corpi in Australia.
Messaggi dall’oltretomba
Essendovi oltre a lei solamente pochi archeologi attivi presso una struttura di tafonomia, nota comunemente come «fattoria dei corpi», e grazie all’impiego da parte della borsista degli elementi fondamentali delle scienze forensi, il lavoro sul campo svolto da Schotsmans ha costituito in parte una novità all’interno del mondo dell’archeologia. «Il trattamento funebre dei morti fornisce indicazioni sul comportamento umano, sull’organizzazione sociale e sull’ideologia delle società passate, il che significa che, se vogliamo comprendere una società, è importante effettuare un’analisi adeguata dei relativi trattamenti funebri», osserva Schotsmans. Gli esperimenti di Schotsmans, condotti presso l’Australian Facility for Taphonomic Experimental Research(si apre in una nuova finestra) (AFTER), si sono incentrati sulle sepolture e sulle sequenze mortuarie avvenute nel Vicino Oriente durante il Neolitico. Secondo Schotsmans, questo lavoro ha permesso di trarre migliore indicazioni in merito ai processi relativi alla mummificazione naturale. Per esempio, i ricercatori hanno dimostrato che le mummie, come tutti gli esseri umani, attraversano le fasi standard della decomposizione, dal rigonfiamento all’intensa putrefazione, passando per la fuoriuscita dei fluidi di decomposizione. «Non è possibile che una persona dall’essere fatta di carne e ossa entri in uno stato di mummificazione senza prima perdere umidità e fluidi», spiega Schotsmans. «Vi è pertanto un malinteso circa la convinzione secondo cui la putrefazione, nelle mummie, viene interrotta o non si verifica.» I ricercatori hanno inoltre identificato il flusso d’aria e l’evaporazione quali fattori chiave nel processo di mummificazione. «Spesso si ritiene che a tal fine siano necessarie condizioni secche, ma le mummie possono crearsi anche con precipitazioni a frequenza giornaliera e presenza di forti venti», afferma Schotsmans. «Siamo riusciti a ottenere la miglior mummia durante la stagione delle piogge australiana, quando le precipitazioni avvenivano quotidianamente e le temperature erano elevate, con un buon flusso d’aria.»
I morti e i putrescenti
La ricerca di Schotsmans mostra chiaramente che non è possibile svolgere un’accurata analisi archeoantropologica senza studiare l’ambiente di deposizione e comprenderne i relativi processi associati. «Sono molti gli archeoantropologi che non hanno mai avuto a che fare con un morto o con un corpo in decomposizione», afferma. «Senza comprendere la decomposizione e i fattori che incidono su di essa, tuttavia, analizzare i resti scheletrici e interpretare le pratiche funebri si rivelano compiti estremamente difficili.» Sebbene possa sembrare ovvio, a detta di Schotsmans il messaggio più importante fornito da questo progetto è quello di non applicare metodi in modo troppo rigoroso senza procedere a una riflessione critica. «Le ipotesi e le interpretazioni dovrebbero essere trattate con cautela e convalidate», dichiara l’archeologa, che conclude: «Gli approcci sperimentali rappresentano una preziosa integrazione alla ricerca archeologica e antropologica.» La ricerca di Schotsmans è stata pubblicata in un libro sull’archeotanatologia curato da lei stessa congiuntamente al ricercatore Christopher Knüsel(si apre in una nuova finestra). La borsista darà inoltre seguito ai propri esperimenti in Australia grazie a una sovvenzione assegnata dal Consiglio australiano di ricerca(si apre in una nuova finestra).